Programma Voyager, testimone della grandezza umana
- Alberto Alpi
- 6 dic 2017
- Tempo di lettura: 5 min
Siamo nel 1977, in piena guerra fredda. La corsa allo spazio ha appena subito un enorme svolta: la conquista della luna il 20 luglio del 1969, la quale più che un punto di arrivo divenne un un punto di partenza. L'uomo è qualcosa di grande, di incredibile, le capacità dell'uomo son riuscite a calcolare e prevedere nei minimi dettagli un viaggio di circa 384'400 km. Atterraggio e decollo dal suolo lunare e rientro in patria, la nostra meravigliosa biglia blu. Ed è proprio in questo scenario storico che nacque uno dei programmi spaziali più interessanti ed incredibili di tutta la storia umana.

Il programma Voyager, inizialmente comprendeva due sonde destinate allo studio del sistema solare esterno, comprendente quindi tutti i corpi celesti tra la fascia principale di asteroidi e la nube di Oort; in poche parole: Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
Voyager 1 e Voyager 2 sono le due sonde che furono progettate e costruite dalla NASA per questo programma e che, tuttora funzionanti, ci permettono di dare uno sguardo e studiare l'universo a più di 130 UA* da noi. Voyager 1 con un destino più "semplice" che comprendeva il viaggio interstellare fino a Giove, un suo studio in fase di avvicinamento e poi, sfruttando l'effetto gravitazionale del gigante gassoso un secondo viaggio fino al raggiungimento di Saturno. Ultima tappa del programma sarebbe stata lo studio del celeberrimo pianeta con gli anelli ma in un secondo momento, vista l'ottima condizione degli strumenti, si è optato per continuare la missione lanciando letteralmente la sonda verso lo spazio inesplorato, lontano da ogni corpo celeste conosciuto, alla scoperta dell'ignoto. Destino diverso invece è toccato alla Voyager 2 che oltre allo studio ed il sorvolo di Giove e Saturno, sfruttando una congiunzione favorevole, ha sfiorato anche i due pianeti più esterni, Urano e Nettuno, proseguendo poi con un progressivo allontanamento dal centro del nostro sistema solare.

Step del programma Voyager
Il lascito ai profani di Voyager 1 si può riassumere in qualche album di fotografie e poco altro, tra cui quella di cui ho già parlato in quest'altro articolo (Blue Pale Dot). Al contrario, ad un occhio più attento ed educato è evidente la mole di informazioni e dati che la sonda ci ha fornito, sia sui giganti che ha visitato che sulla conformazione del nostro sistema solare. Nel novembre 2004 venne superato dalla sonda il termination shock , confine oltre il quale il vento solare rallenta fino a velocità subsoniche causa interazione con il mezzo interstellare. Conseguenza di questo “scontro” è il riscaldamento della zona circostante e una variazione del campo magnetico, siamo tra le 75 e 90 UA dal Sole. Il confine non è fisso ma variabile a seconda dell'attività solare. In parole povere, il sistema solare si muove nello spazio il quale oppone una resistenza, seppur minima, ed a distanze siderali dal sole si viene a creare una sorta di effetto goccia orientata nel senso del moto del nostro sistema solare. Effetto visivamente paragonabile ad un proiettile che attraversa l'aria e che la deflette attorno ad esso. I dati di questo attraversamento son tutt'ora incerti causa malfunzionamenti in alcuni sistemi ed apparecchi che avrebbero dovuto calcolare dati a riguardanti il campo magnetico e l'incidenza del vento solare. Oltre il termination shock troviamo l'eliopausa, punto in cui il vento solare viene totalmente bloccato dal mezzo interstellare, zona in cui la sonda è entrata il 13 dicembre 2010. Per finire, il 25 settembre 2012 la NASA ha confermato che dopo svariati dati inviati e studiati dai ricercatori la sonda, ad ormai 121 UA dal sole, era ufficialmente entrata nello spazio interstellare. La sonda tutt'ora si trova a viaggiare a 17 km/s nel vuoto più totale e proprio pochi giorni fa è stato eseguito un tentativo, con ottimi esiti, di riattivazione dei pochi strumenti rimasti attivi. I propulsori principali la quale funzione era quella di mantenere correttamente l'orientamento dell'antenna verso la terra, essendo molto usurati ed a corto di carburante son stati momentaneamente spenti e per compensare a questa mancanza son stati riattivati dei propulsori secondari inutilizzati da circa 40 anni che a differenza dei primi, utilizzano energia elettrica. La cosa incredibile sta nel fatto che grazie a questa manovra, che con tutta probabilità sarà effettuata anche sulla seconda sonda (Voyager 2), abbiamo allungato la vita del progetto fino al prossimo decennio. Al termine dell'energia si spegneranno i propulsori secondari e verranno riattivati i primi fino al termine della vita della sonda. Voyager 1 ora si trova a 141 UA dal Sole e per comunicare con lei occorrono circa 20 ore, in totale 40 ore per ricevere una risposta, stiamo in fondo parlando dell'oggetto più lontano dalla terra che l'uomo abbia mai costruito.
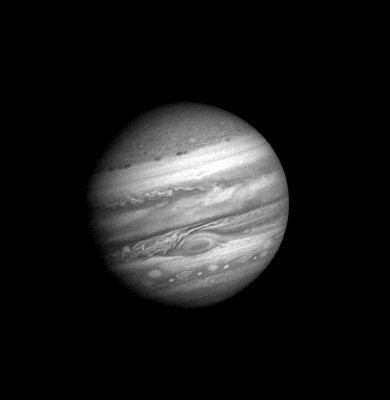
Avvicinamento di Voyager 1 a Giove
Per quanto riguarda Voyager 2, oltre alle notevoli quantità di informazioni riguardanti i pianeti da lei visitati, ci è risultata enormemente utile per confermare i dati raccolti dalla sorella maggiore (Voyager 1) in quanto dopo il saluto a Nettuno la sonda ha superato il termination shock l'11 dicembre 2007. In questo caso le strumentazioni erano perfettamente funzionanti ed han potuto confermare i dati incerti che 3 anni prima ci aveva fornito Voyager 1. Ora si trova a circa 116 UA dal sole e per comunicare con lei occorrono “solo” 16 ore, 32 in totale per ricevere una risposta, viaggia a 15 km/s , velocità destinata a diminuire, seppur molto lentamente, data la differente angolazione di uscita dal sistema solare rispetto alla sorella la quale era sfuggita alla gravita del sole quasi perpendicolarmente al senso di marcia del nostro sistema solare. A bordo della Voyager 2, come per la sorella maggiore, abbiamo un disco registrato, placcato in oro, contenente immagini e suoni della terra in caso di un possibile contatto con altre civiltà intelligenti in grado di decifrarlo. Stiamo parlando del Voyager Golden Record, fortemente voluto da Carl Sagan, che oltre a quanto sopra citato ha anche fornito il disco di una copertina su cui si trova una sorta di istruzioni per accedere ai dati registrati al suo interno. Sulla copertina troviamo la posizione della terra secondo 14 pulsar note, stelle notoriamente fisse, con indicato in codice binario la frequenza delle loro pulsazioni. Subito sotto, sulla destra abbiamo la rappresentazione dell'idrogeno, elemento più presente e fondamentale per il nostro universo e sopra abbiamo le istruzioni per leggere e decodificare il cd all'interno.

Copertina e disco del Voyager Golden Record
Cosa ci resta di tutto questo? Come può cambiare la nostra vita a seguito di questa spedizione? Concretamente in niente, stiamo parlando di cose così distanti e lontane che mai potrebbero tangerci minimamente, o almeno, questo potrebbe essere il ragionamento di una qualsiasi persona troppo impegnata nella sua minuscola realtà che non ha la forza e l'interesse di alzare lo sguardo e cercare di capire quanto l'uomo possa essere grande. Stiamo parlando di oggetti concepiti e programmati 40 anni fa che tutt'ora svolgono compiti di importanza colossale per i ricercatori. Stiamo parlando della più alta evidenza dell'intelligenza umana, capace di creare e prevedere traiettorie sconosciute alla pratica ma solo tramite formule teoriche; è quasi commovente sapere che centinaia di uomini, qui, sulla terra siano legati così fortemente ad oggetti così lontani da sembrare impalpabili, inesistenti, astratti. L'uomo con questo progetto ha costruito due sentinelle e le ha spedite dove nell'immediato futuro non si sarebbe mai potuto spingere fisicamente. Loro sono i nostri due migliori soldati, sono il nostro braccio bionico, sono la stampella per l'anziano, sono il bastone per il non vedente. Loro sono l'orgoglio di centinaia di scienziati che giornalmente cercano di dare risposta all'antichissima domanda: ma noi, cosa ci facciamo qua?

Panoramica eseguita da Voyager 1 a tutti i pianeti del nostro sistema solare, tolto Mercurio, troppo vicino al Sole per essere distinto da distanze così elevate
Se volete dare un'occhiata in diretta ai dati della missione eccoli qua: Voyager NASA
*UA: Unità Astronomica, unità di misura utilizzata all'interno del nostro sistema solare. 1 UA equivale alla distanza media tra Sole e Terra, circa 150 milioni di kilometri, per l'esattezza 149'597'870,700 km. Rispettivamente equivalente a 0,0000158 anni luce.

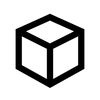
Comments