"Il turno di notte": la poesia di Sarajlic in tempo di barbarie
- Michele Donati
- 30 nov 2017
- Tempo di lettura: 4 min
“Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie”, sentenziava Theodor W. Adorno, ritenendo che la cultura e la barbarie stessa fossero giunte al loro ultimo stadio. Era il 1949 e lo shock dei campi di concentramento turbava la coscienza sporca dell’Occidente, come dopo un oscuro incubo notturno: le dimensioni apocalittiche del genocidio e il sorgere di un’iconografia di massa avevano conferito alla tragedia ebraica i tratti dello spartiacque storico. La pianificazione sistematica di atti disumani segnava un punto di non ritorno sul piano etico ed estetico, dal momento che nell’immaginario collettivo era entrata una realtà oscena, e con essa una struttura di rappresentazioni altrettanto crude. Perché coltivare l’evasione dell’Arte mentre la Realtà pretendeva una disincantata presa di coscienza (individuale e collettiva) degli avvenimenti storici? A ben guardare, la domanda avrebbe una sua ragion d’essere in qualsiasi secolo, ma i primi a porsela in maniera drammatica sono stati gli uomini del ‘900, alle prese con mutamenti destabilizzanti e violenze sfacciate: la verità, però, è che il lager non è il compimento degli orrori dell’uomo, e dopo Himmler altri carnefici hanno macchiato di sangue il terreno della Storia. Si potrebbe dire, anzi, che la logica nazista dello sterminio sia sopravvissuta al processo di Norimberga, assumendo forme, collocazioni geografiche e sociali differenziate, divenendo tentazione latente anche in sistemi politici democratici, sfociando nell’effettiva attuazione in situazioni straordinarie di crisi. Come è possibile scrivere poesie dopo le stragi in Palestina o dopo gli innumerevoli naufragi nel Mar Mediterraneo? “Come può un poeta essere amato”, si chiedeva Antonio Porta nella raccolta Invasioni del 1984, se “sono già pronte bombe per 250.000 Hiroshima”? Eppure di versi se ne continuano a scrivere (anche in eccesso probabilmente) e le atrocità che si compiono non sembrano valere come impedimento morale per gli artisti: talvolta, addirittura, si verifica quello strano fenomeno per il quale, dallo stimolo etico dello scontro con il male, si trae la linfa da far scorrere in una forma estetica. È anche così, attraverso la poesia, che la realtà sanguinosa viene riscattata: i versi si immergono in essa e quando tornano a galla offrono il trauma del dolore e dell’ingiustizia perché possa essere superato.
A coltivare con fede la pianta della poesia in un prolungato inverno di barbarie vi fu, tra gli altri, Izet Sarajlić: nato nel nord della Bosnia nel 1930 e morto a Sarajevo nel 2002, visse due volte la tragedia della guerra, facendosene testimone. Durante il secondo conflitto mondiale perse infatti il fratello, ucciso dalle camicie nere di Mussolini, e la guerra che negli anni ’90 ha straziato la Bosnia gli portò via anche le amatissime sorelle, Nina e Raza. La sua vicenda umana e poetica torna adesso di stretta attualità con la pubblicazione, per Multimedia Edizioni e a cura della Casa della Poesia di Baronissi (SA), del Libro degli addii, congedo in versi ed estremo canto di un’esistenza drammatica. Ironia della sorte, il libro ha visto la luce proprio nei giorni in cui Ratko Mladic, generale serbo responsabile di torture, deportazioni e genocidi, veniva finalmente condannato in primo grado all’ergastolo dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia. Tra gli innumerevoli crimini commessi, Mladic è responsabile del genocidio di Srebrenica, che nel luglio del 1995 vide sterminati più di ottomila musulmani di etnia bosgnacca, e dell’assedio di Sarajevo, durato dal 1992 al 1996: quasi quattro anni di massacri, con bombardamenti ininterrotti e migliaia di vittime, compresi bambini colpiti dalle pallottole dei cecchini.

Da questa capitale in ginocchio, abbandonata o temuta come una trappola mortale, Sarajlić non se ne andò. Disse addio, l’uno dopo l’altro, ad amici e parenti, passò sui calcinacci dei palazzi sventrati, ma continuò a scrivere, raccontando l’agonia di un Paese e dell’umanità. Non c’è nulla di barbaro (e non se ne abbia Adorno) nei versi di questo poeta, semplici come il pane, asciutti e spesso lapidari, ma aperti ad un’umile, coraggiosa resistenza contro la cecità bellica. Vi è, al contrario, un avvertimento per tutte le generazioni, e una vocazione: “[…] Dovevamo riabilitare tutte le parole dell’uomo / perché da coltello fino ad erba / tutte erano macchiate di sangue […]”. E tra le parole da salvare ce n’è una che il nostro Occidente, addormentato sul divano del benessere, ha banalizzato, disossato e reso superflua: Amore. Pensiamo invece quanto dovesse apparire necessario e complesso questo sentimento ad un uomo cui la guerra non aveva risparmiato nulla. Come Ungaretti, anche Sarajlić ha scritto “lettere piene d’amore” con lo scempio dei compagni massacrati negli occhi, ed ha accolto nella propria poesia una pietà per i vinti di fattura essenziale, priva di orpelli e vanità, il pianto genuino e la scintilla della libertà. L’oblio del passato genera i mostri del presente, il silenzio degli uomini genera il chiasso della Storia: proprio per questo è indispensabile non tacere, non appendere le arpe ai salici. D’altra parte “chi ha fatto il turno di notte per impedire l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti”: il turno di notte è il lavoro più ingrato, il meno esposto agli occhi degli altri e al loro plauso, ma anche la veglia affettuosa di chi è disposto a perdere il sonno per il bene comune.


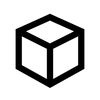
Comments