Caso Balthus: autonomia dell'arte e bigottismo americano
- Michele Donati
- 7 dic 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Al gatto che mangia tranquillo il proprio pasto poco importa della gonna alzata di Thérèse e dei suoi occhi socchiusi in un momento di autoerotismo. Gatti e adolescenti sono due elementi che ricorrono frequentemente nell’opera di Balthus, pittore singolare fin dal giorno della nascita, avvenuta a Parigi il 29 febbraio del 1908. Mentre suoi personaggi sembrano sospesi nel tempo e sostanzialmente indifferenti al contesto esterno, tra solitudini che riecheggiano la Metafisica e impasti cromatici vicini al mondo assorto di Piero della Francesca, il pubblico dei musei non sempre dimostra un uguale distacco, ed anzi pare più incartapecorito di certe statue âgée. È di questi giorni la polemica sorta negli States intorno a “Thérèse dreaming”, dipinto balthusiano conservato al Metropolitan Museum di New York: una petizione che chiede di rimuovere il quadro, colpevole di “romaticizzazione del voyerismo e reificazione dei bambini”, ha raggiunto in un baleno le 9000 firme, favorita dal clima particolarmente ostile ai reati sessuali che si respira al momento oltreoceano. Senza dubbio la denuncia delle molestie è un bel passo avanti dal punto di vista sociale, ma sarebbe opportuno anche tenere a debita distanza spettri quali la psicosi da ignoranza.

Qualche puntualizzazione sull’opera in questione è d’obbligo. “Thérèse dreaming” fu realizzato da Balthus nel 1938: fra il ’36 e il ’39 l’artista firmò una serie di ritratti della piccola Thérèse Blanchard e dei suoi fratelli, trasformandola in un simbolo dell’erotismo nell’età tra infanzia e maturazione. Si tratta di un tema principe non solo per il pittore: il XX secolo ha consegnato alla letteratura la definizione freudiana di “perverso polimorfo”, vale a dire il bambino che durante il proprio sviluppo sperimenta in vari modi la ricerca del piacere fisico senza finalità riproduttive. Attraverso tale ricerca l’infante giunge ad una coscienza della propria identità e del proprio corpo. Ancora più vicino a noi è il caso di “Lolita”, capolavoro di Vladimir Nabokov pubblicato dopo mille traversie nel 1955: nel libro è narrata l’oscura passione del professor Humbert per la “ninfetta” dodicenne Dolores. Lolita è completamente assorbita dall’ego del suo amante e privata di autonomia narrativa, ridotta quindi a oggetto di desiderio. Se a commentare i lavori letterari fossero solo i bigotti, la vicenda sarebbe uno scabroso esempio di pedofilia , ma dal momento che questo lavoro deve svolgerlo la critica, basandosi su parametri estetici, si dirà che Nabokov è riuscito a trasfigurare i torbidi istinti del suo personaggio in sublime affabulazione letteraria, centrando l’obiettivo di trascinare il lettore in un raffinato labirinto romanzesco da cui i moralismi sono estromessi per lasciare all’invenzione il suo sacrosanto spazio. Ma si può risalire anche indietro di secoli per osservare come l’arte abbia raccontato spesso e volentieri la fisicità degli adolescenti. Chi è pronto, per esempio, a lanciare una petizione per censurare la stragrande maggioranza della mitologia e della cultura classica, in cui ragazzine erano stuprate da divinità e vecchi filosofi si occupavano dell’iniziazione all’età adulta dei propri allievi? Oppure vogliamo coprire con un pietoso velo anche tutte le Natività, da Giotto a Rubens passando per il presepe sotto l’albero, perché ci presentano una dodicenne usata come utero in affitto? Il nostro periodo è innamorato della denuncia, e probabilmente amerebbe ancora gogne pubbliche, ghigliottine e vergini di Norimberga per tutti i furfanti che osano allontanarsi dal giornalismo d’inchiesta per scrivere un racconto o dipingere una tela in libertà. I 9000 firmatari della petizione che chiede la censura per “Thérèse dreaming” ignorano che la funzione sociale dell’arte non è dare la buonanotte ai figli del pastore protestante: essa, invece, deve garantire la sopravvivenza di un spazio di libertà individuale all’interno di un contesto che da un lato va verso la massificazione e dall’altro verso l’egocentrismo. Il linguaggio estetico è differente dal linguaggio etico, e tra queste due sfere corre la differenza che sta fra rappresentazione e realtà empirica. È con quest’ultima che una morale efficace deve misurarsi, lasciando agli artisti il compito di trasfigurare, quando lo vogliano, abissi o nevrosi. Oppure di rappresentare semplicemente una realtà che può scandalizzare solo le beghine yankees, la masturbazione adolescenziale. Dunque bene ha fatto il portavoce del museo Metropolitan, Ken Weine, a ribattere che “l'arte visiva è una delle più importanti forme di espressione di cui disponiamo per riflettere sia sul passato che sul presente”, rifiutando così ogni ipotesi di censura. Con buona pace di chi, ergendosi a paladino dei diritti, manifesta solo mancanza di elasticità mentale.

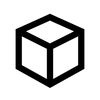
Comentarios