Natura non-morta o l'arte generativa di internet
- Luisa Maria Mae
- 6 gen 2018
- Tempo di lettura: 5 min
Il tardo capitalismo ci diede il computer. Poi venne l'immaginario videoludico, poi la virtual plaza.
Oggi il regno virtuale è una dimensione autonoma. Per noi non sempre è un semplice mezzo: è il fine stesso. È la realtà aumentata che ci consente molte più esperienze di quelle che potremmo vivere in una preconfezionata esistenza quotidiana. Nell'"epoca della riproducibilità tecnica" le opere d'arte prodotte in serie, nichiliste e/o annichilite, siamo noi. Però questo è qualcosa che raccontiamo da tanto tempo, e mentre ce lo raccontiamo – anche sulla piazza virtuale, fra un
corto animato e l'altro – restiamo sordi.
Nel frattempo, se l'ambiente post-moderno ci opprime e depersonalizza, cresce una realtà parallela che tramite noi acquista sempre più marcatamente attributi quali individualità e personalità.
Abbiamo costruito selve digitali ed esse esistono, producono, indipendentemente da noi singoli. Internet è uno specchio che ci riflette (deformati, perlopiù) ma intanto cresce da sè, come con il disinteresse di un ecosistema naturale. Mi viene in mente Werner Herzog che, a proposito della foresta amazzonica, disse: «It's the only land where creation is unfinished yet».
Per quanto ci siamo costantemente, profondamente immersi, il mondo virtuale è ancora qualcosa che non sappiamo regolare nè definire precisamente. Marx scrisse che «la moderna società borghese [...] è come il mago che non è più in grado di controllare i poteri del mondo degli inferi che egli stesso ha evocato con le sue formule». Che internet sia infernale o meno, è vero che la tecnologia informatica ha creato entità ambigue – AI a parte – in una dimensione fra l'astrazione e la materialità, fra la pura macchina e il feticcio affettivo. È vero che senza il nostro smartphone ci sentiamo persi e deboli: senza di esso ci manca un luogo dove viviamo quotidianamente, ed in un certo senso ne siamo mutilati. È vero che in una (bidimensionale) disposizione di pixel esiste al contempo un mondo (pluridimensionale) che si sviluppa e si ramifica tramite una quantità innumerabile di informazioni.
Così anche ciò che è puramente virtuale acquista un valore di concretezza ed autonomia determinante. E non solo per la nostra azione feticistica verso di esso.
Mentre in internet si stanno depositando le nostre informazioni, emozioni, conoscenze, negli ultimi anni sono nati progetti e opere volte a dare voce e possibilità di espressione ai nostri sistemi informatici. Come se si avvertisse il bisogno di ricevere qualcosa in cambio.
Gli artisti, i programmatori, gli sviluppatori più inquieti dei nostri tempi hanno dato carica artistica – forse persino filosofica – ai programmi che solitamente regolano di nascosto i computer e le piattaforme virtuali.
Per fare un esempio, tempo fa il gruppo AND (Abandon Normal Devices) ha organizzato a Londra The Art of Bots, un festival d'arte digitale volto a presentare la potenzialità creativa dei bots. Si legge nella presentazione dell'evento: «One of the unique characteristics of bots is that they are semi-autonomous: they demonstrate behaviour that is partially the intentions of the programmer (who created the bot) and partially a function of the machine itself. [...] At what point does a bot begin to lead a life of its own? Have bots enslaved us or are they revolutionising the way we create, consume and think?»
Le idee di questa micro-comunità di creativi pongono domande irrisolte sulla relazione tra uomo e intelligenza artificiale, tra artista e artefatto, in una dialettica dove il concetto di arte è ancora soggetto a nuove crisi e rielaborazioni.
È facile porsi scetticamente nei confronti di un'espressione artistica che viene da un computer. Opere come queste consistono in spazi e oggetti che in certo senso si creano da sè, tramite programmi e linguaggi informatici, derivati di algoritmi e di probabilità aleatorie. Eppure possiedono una loro intrinseca bellezza. Non hanno sentimento, non vengono da una coscienza. Ma nell'ecatombe narrativa del terzo millennio, per un attimo non sembra così assurdo soffermarsi su un paesaggio di simboli e pixel o leggere poesie di parole assemblate da calcolatori.


MIRROR LAKE, Katie Rose Pipkin, 2016. Il bot fa crescere un nuovo mini-paesaggio ogni due minuti.

inflorescence.city (vol. 1), Katie Rose Pipkin & Loren Schmidt. Generatore di un periodico misterioso che propone i dati e le storie (tra censimento, cimitero e biblioteca locale) di una città fittizia. Ogni volta che il browser viene ricaricato, il bot "riscrive" una nuova città, tramite algoritmi e frammenti di codice.
Magari non è arte. Ma se è arte, formalmente non è nulla di assolutamente nuovo. Tralasciando che questi sono oggetti virtuali di ordine-disordine matematico, nei risultati essi ricordano il surrealismo e il Cadavre Exquis, il Dada, le forme di scrittura del gruppo OuLiPo, le tante opere di fusione artistica tra creazione umana e tecnica digitale già ampiamente diffuse nella cultura internet.
mothgenerator: twitterbot generatore di falene immaginarie.
Su Twitter fioccano bot generativi che scrivono di qualsiasi cosa sotto forma di poesia. Prendono parola scomponendo la mole informativa che contiene la piattaforma, riassemblata in versi essenziali, simili ad haiku, secondo regole nascoste: Magic Realism Bot (micro-narrazioni dalla magia della combinazione), a strange voyage ("endless nautical story generator"), poems.exe. Fra i twitterbot più suggestivi c'è The Ephemerides, generatore di poesie d'atmosfera surreale in didascalia a fotografie dello spazio prese dai database della NASA.
Anche questi marginali fenomeni artistici dimostrano come i tanti regni del digitale stiano alterando il nostro stato intellettuale e spirituale. Come porsi verso un'immagine o uno scritto che suscita suggestioni estetiche-emotive – penso al senso di nostalgia che in un qualche modo permea alcune di queste creazioni – sapendo che vengono da un puro calcolo? È triste, è perturbante e inammissibile. Esse si trovano in uno stato incerto, fra ciò che crea e ciò che è creato, fra mente e meccanismo.
Tento di riportare un'interessante analogia che Katie Rose Pipkin, artista e programmatrice, ha tracciato in un suo articolo. Nel secolo XI, dal mondo iconolatra bizantino nacque il culto di particolari reliquie cui si attribuiva origine miracolosa: le immagini acheropite. Acheropita significa etimologicamente "non prodotto da mano umana": era l'arte "apparsa", non creata dall'uomo, ma dal diretto intervento divino. Tali icone risiedevano in una dimensione ontologica ambigua e di altissimo valore sacro. Ad oggi Dio è ancora morto e di fronte a creazioni estetiche robotiche difficilmente saremo colti da pensieri mistici. Ma se ricordiamo il feticismo sacrale che le nostre abitudini e la nostra mentalità riservano alla tecnologia, troveremo un'affinità. Chiamare arte questi giardini digitali sarà l'ennesima morte dell'arte. Ma fa riscoprire un senso di bellezza molto simile a quello della contemplazione di un fiore o di un cristallo di ghiaccio. Non ha politica nè significato al di fuori di sè. Ricordo parole di Lou Reed: «I like mindless disco. They say the lyrics are stupid and repetitious. So what's wrong with that? So is lying in the sun.» Questo mondo virtuale, evocato da noi e fuori dal nostro controllo (Marx), paradossalmente dà le stesse suggestioni di un mondo naturale che crea e si plasma secondo casualità, leggi meccaniche e ingiustificabili, caos e basta. A comando o meno, questo universo ricomincia o continua il proprio processo generativo. «The only land where creation is unfinished yet»?

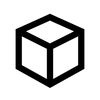
Comments